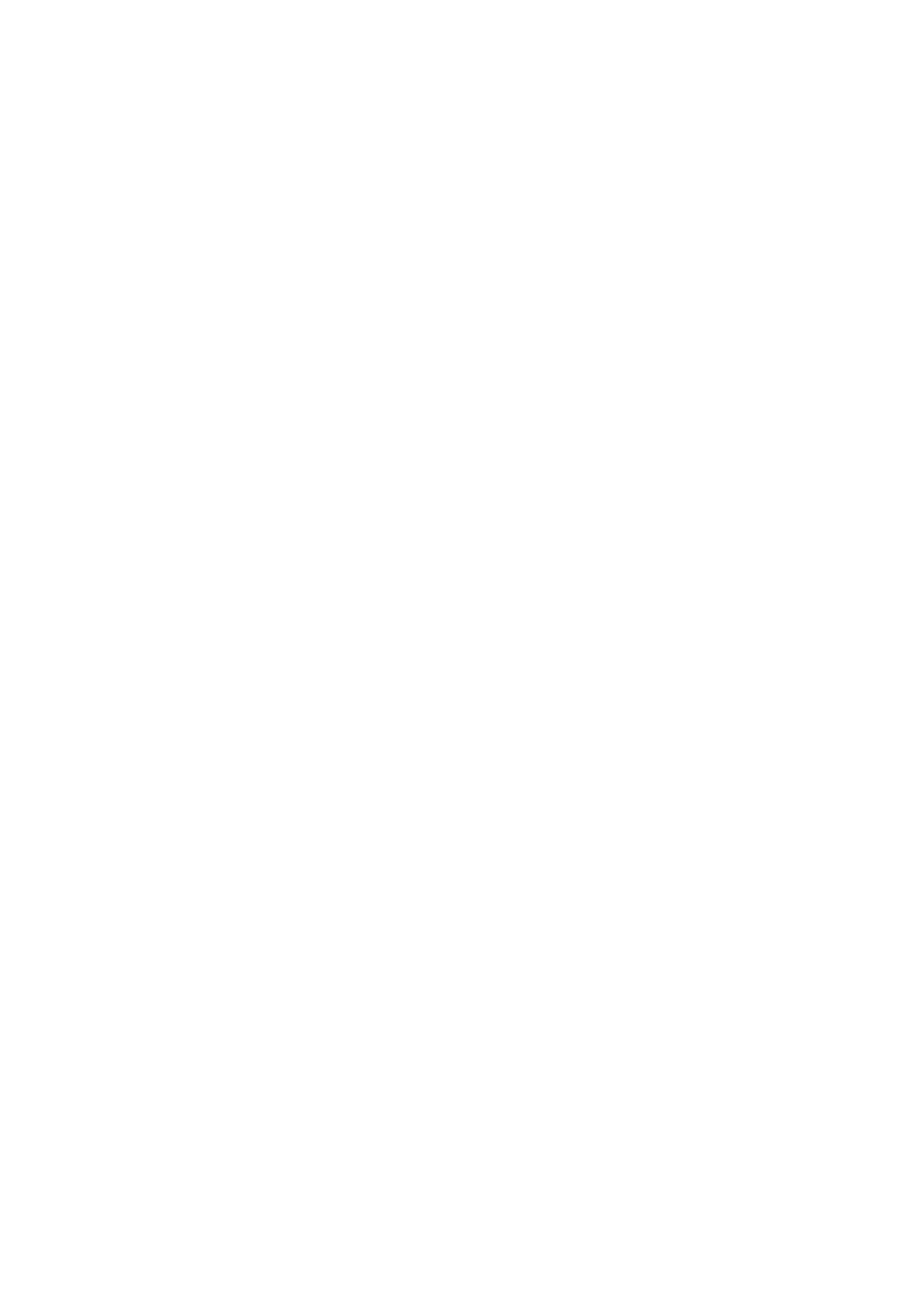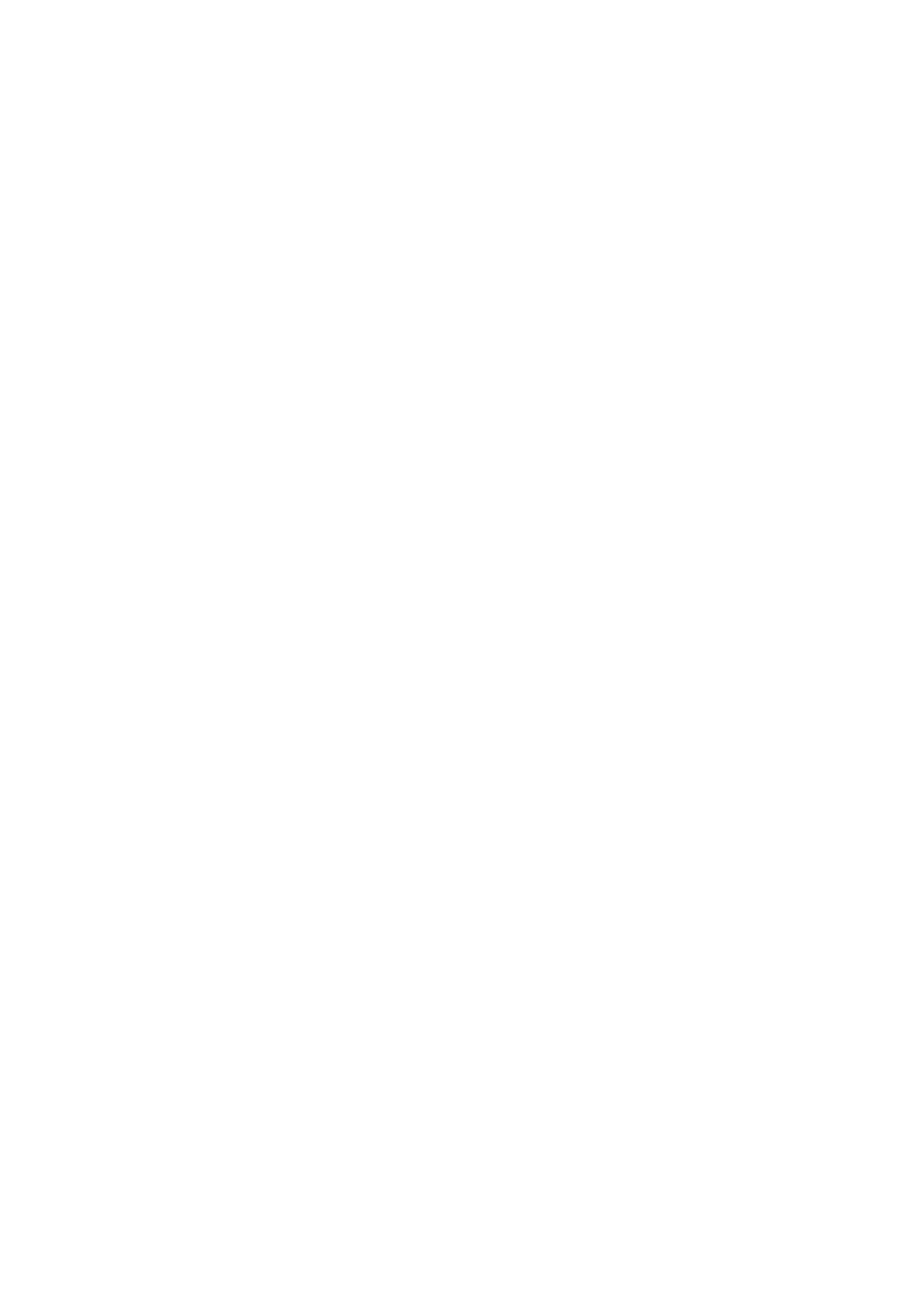
Per una politica europea di asilo, accoglienza e immigrazione
non riesce lui stesso a capire il senso delle affermazioni della madre durante il
colloquio in presenza degli operatori; nota che la signora tenta di raccontare la sua
vita intera e non solamente l’episodio, chiede agli operatori di sospendere il
colloquio a tre (operatori/mediatore/utente) per consentirgli di ascoltare l’utente
da solo. Dopo mezz'ora di racconto emerge un’esistenza caratterizzata dalla morte
del capo famiglia nel primo anno di arrivo in Italia che lascia la moglie casalinga
sola a badare ai cinque figli; poi, dal sostegno dei servizi (inserimento dei figli in
comunità per minorenni); quindi, dal ritorno dei figli a casa dopo che la signora ha
riacquistato la sua autonomia; poi, ancora, dal non adattamento della figlia piccola
a scuola e dalla difficoltà della madre a educarla, fino all’inserimento della figlia in
una nuova comunità per minori. Il suo discorso è lineare e coerente, poi alla fine, la
signora, che apprezza l’operato degli educatori in generale, aggiunge “
ma loro
devono sapere che ora lei ha fatto il Ramadan
”. Vedendo l’espressione interrogativa
nel volto del suo interlocutore, la signora dice: “
si vede che sei un figlio delle scuole e
non capisci il nostro linguaggio
”, per poi aggiungere con un rossore nelle guance
“
mia figlia ha fatto l’hammam
”. Al ritorno nel gruppo, il mediatore interculturale
chiede alla signora di raccontare il rito di passaggio dall'infanzia all'età adulta
riservato alle femmine, chiamato comunemente il rito dell’
hammam,
perché
avviene nel bagno pubblico in seguito al primo lavaggio dopo il primo ciclo. Il
mediatore spiega agli operatori che il ricorso dell’utente a un linguaggio che trova
le sue radici nel gergo femminile che nemmeno i maschi della stessa cultura
riescono a decifrare, era un tentativo, inconsapevole ma indispensabile per lei, di
attirare la loro attenzione sull'esigenza di accompagnare sua figlia nella fase
adolescenziale prendendo in considerazione la sua doppia appartenenza all'Italia,
dove è cresciuta e dove vive, e al paese di origine, da dove proviene lei e la sua
famiglia.
7.
Per una nuova rinnovata funzione della mediazione interculturale
Quando il mediatore interculturale informa gli operatori sui codici che
regolano le relazioni e i rapporti all'interno di un determinato gruppo, li offre come
strumenti aggiuntivi per potere confermare o modificare i loro strumenti
professionali.
Quando interagisce nella dinamica del colloquio, evocando gli elementi che
condivide con l’utente come lo
status
del migrante, la provenienza dallo stesso
contesto o da un contesto simile (extracomunitario o neo-comunitario, area
geografica, religione, lingua, continente o altro), il mediatore contribuisce a
relativizzare l’alterità dell’utente/paziente di fronte all'équipe terapeutica o socio-
educativa e costruisce attorno a lui un mondo creolo dove possono comunicare
mondi diversi e dove si può dire il non dicibile quando si tratta di una cultura
legittimata, sapiente e dominante contro una cultura popolare e minoritaria.
Di fronte alla forza dell’universalismo dello “scientifico” o del “normativo” -
che può diventare facilmente il mezzo con il quale i gruppi dominanti argomentano
per sottomettere i gruppi minoritari -, l’utente può alzare la bandiera del
44