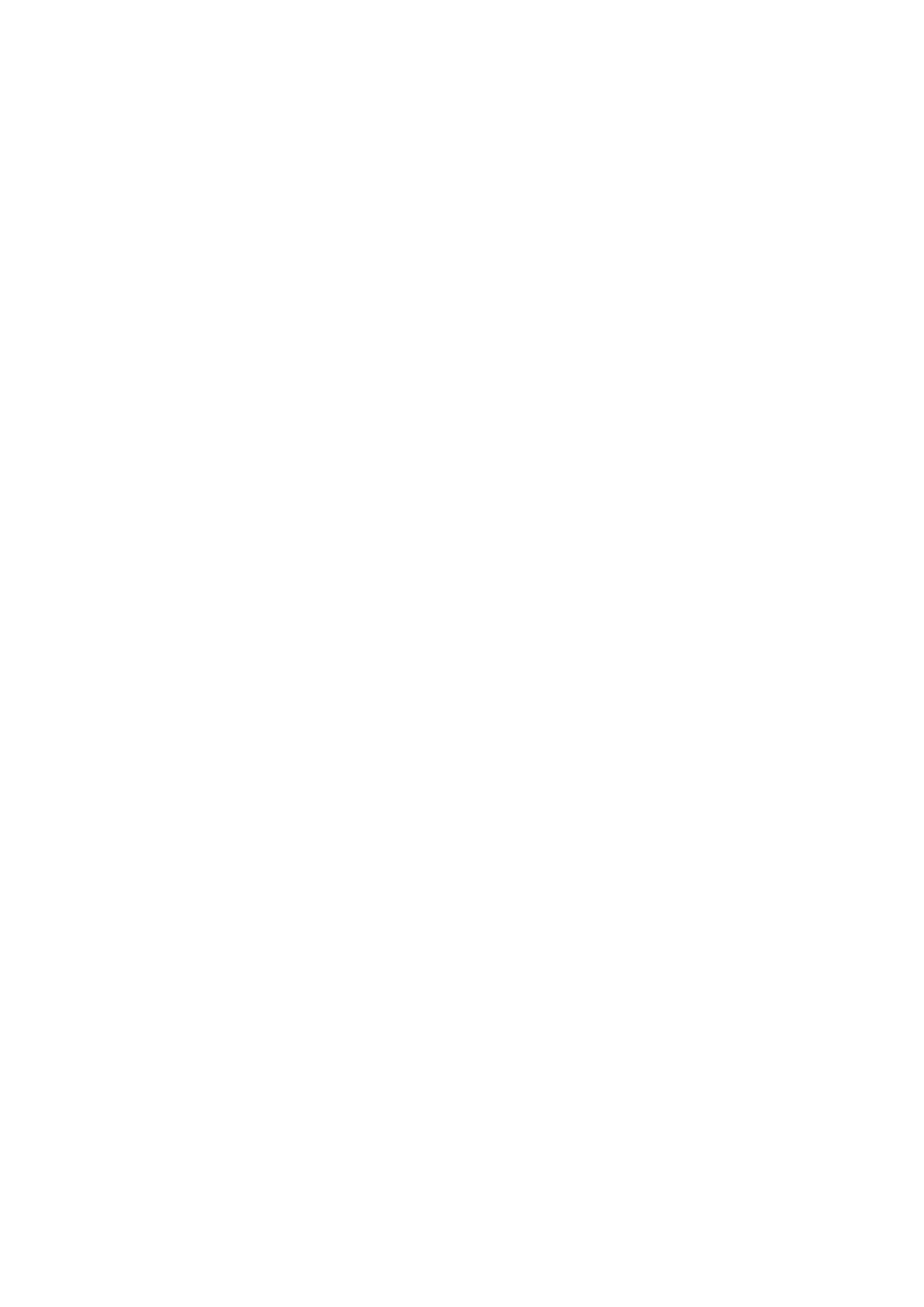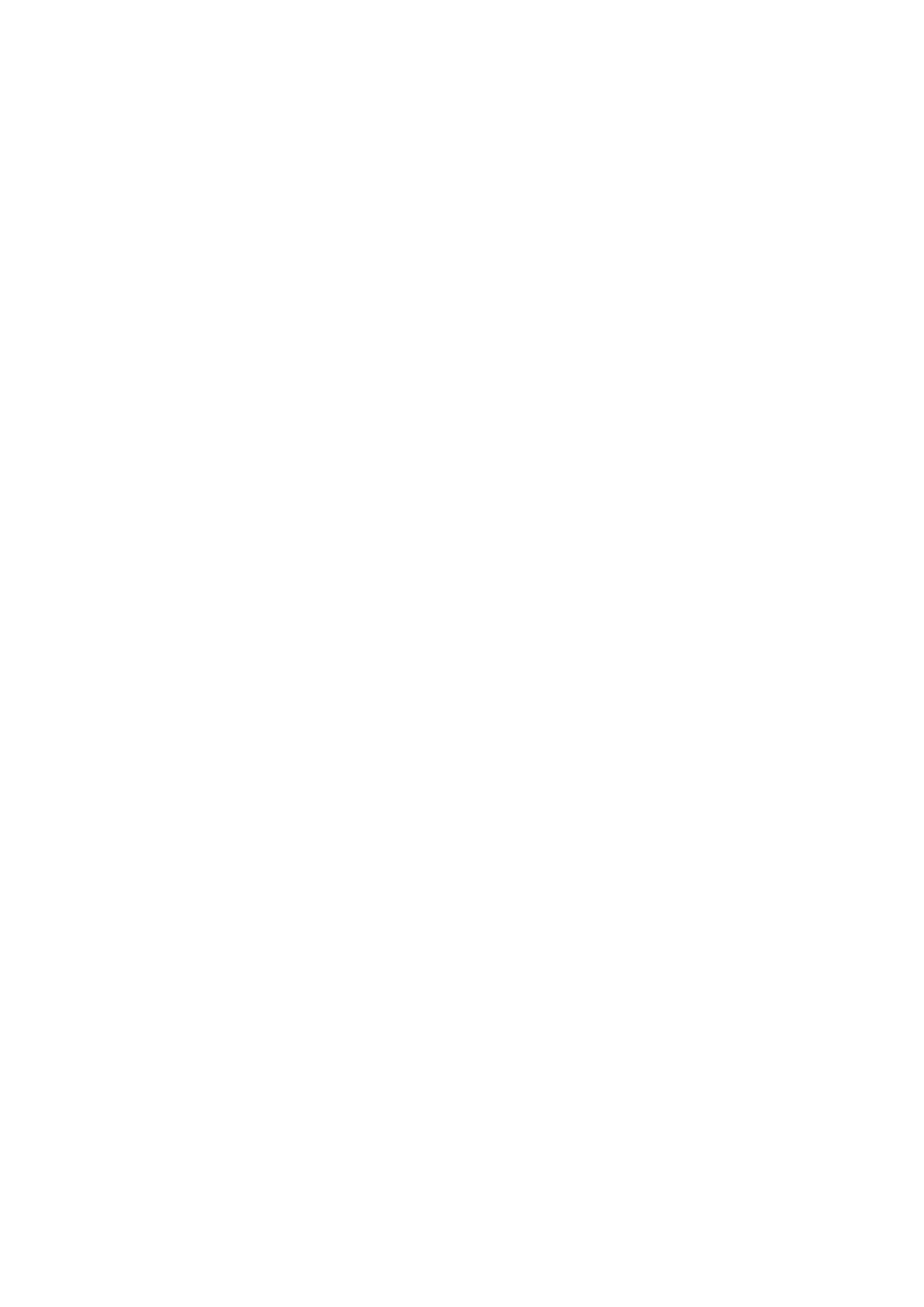
Per una politica europea di asilo, accoglienza e immigrazione
Nel perimetro delle politiche migratorie, gli effetti di questa contraddizione
di fondo sono molteplici: dall’annosa questione della gestione comune delle
frontiere esterne (che spiega, in parte, l'equivoco funzionamento dell’Agenzia
Frontex
), alle incongruenze del Regolamento di Dublino III (la cui applicazione,
spesso, si traduce nella negazione per profughi e rifugiati del diritto di
spostamento all’interno dell’area Schenghen, creando una discrepanza di
condizione rispetto agli altri residenti UE), alle difficoltà nella creazione di un reale
Sistema Comune di Asilo che garantisca eguali condizioni di accoglienza in tutti gli
Stati membri. Sta di fatto che le conseguenze più drammatiche di queste deficienze
si concentrano nelle dispersioni umane: quelle dei profughi che perdono la vita
quasi quotidianamente negli attraversamenti marittimi o via terra, e quelle di
coloro che, pur approdati nei territori europei, scompaiono dai contesti che li
hanno temporaneamente ospitati, senza avere avuto l’opportunità di integrarvisi
socialmente ed economicamente.
2.
Dall’asse interno a quello esterno: l’opzione del
Global approach to
migration
Per quanto importanti e spesso sottovalutate, le contraddizioni strutturali
dell’assetto europeo non bastano a spiegare completamente l’inadeguatezza delle
risposte finora date alle urgenze delle migrazioni forzate. Nella complessità delle
motivazioni, va infatti rimarcata l'ostinata volontà di fare dell’immigrazione una
questione prevalentemente di politica interna, da affrontare, cioè, primariamente
sull'asse interno delle politiche UE, con collegamenti poco organici con altri due
fronti fondamentali: quello economico e quello esterno. Si tratta di
un'autoreferenzialità che avvita la questione su un piano meramente securitario,
catalizzando le risorse economiche verso operazioni di controllo (delle frontiere
esterne e dei profughi sui territori europei) gestite, per lo più, da organismi di
polizia o militari, senza permettere la pianificazione di reali strumenti di
integrazione dei profughi. In questo quadro, l'accoglienza appare destinata a
rimanere in una dimensione puramente assistenziale e l'intero fenomeno delle
migrazioni forzate a essere affrontato come una contingenza passibile solo di
strumenti eccezionali.
Per quanto costituisca un orientamento radicato e sostenuto dalla
maggioranza dei Governi europei, i fallimenti di questo approccio (basterebbe il
numero di naufragi nel Mediterraneo a dimostrarli) dovrebbero indurre a valutare
concretamente un radicale cambio di verso, che metta in seria discussione il
primato del
fronte interno
e inquadri le migrazioni nell’operatività della PESC, con
particolare riguardo per gli strumenti della cooperazione.
Nonostante la copiosa letteratura sul
co-development
sviluppatasi dalla
seconda metà degli anni ’90 e assunta a prassi da numerose Ong, a livello politico
62